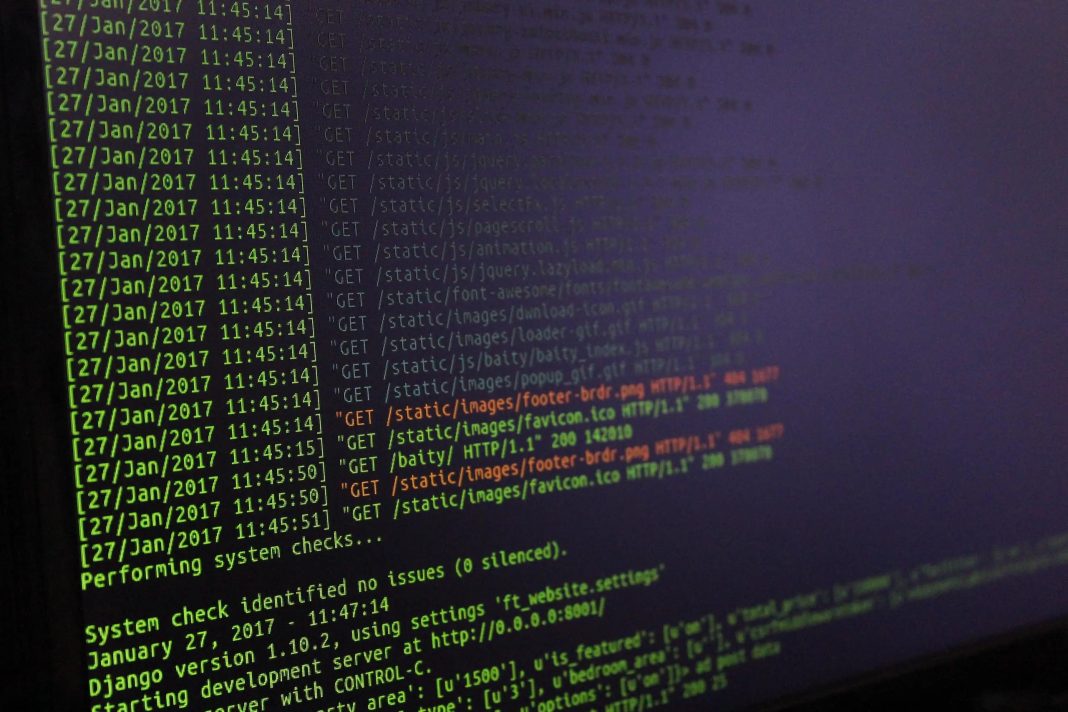Il crollo della globalizzazione finanziaria occidentale, statunitense ed europea, annunciato dalla crisi economica del 2008 e accelerato dalla crisi pandemica del 2019-2020, si sta oggi trasformando in una conclamata crisi politica mondiale; e, sullo sfondo, una crisi climatica inarrestabile, non contrastata per non rinunciare alle antiche predazioni di un capitalismo estrattivo e colonialista, in armi contro il mondo. I vecchi e nuovi strumenti di guerra, dalle cannoniere alle piattaforme digitali, con tutti i loro corollari di propaganda mediatica e di esercizio autoritario dei poteri, stanno registrando arresti e sconfitte in ogni scenario. L’estensione di una guerra globale occidentale contro il “sud” del mondo in una visione di resa dei conti militare con la Russia e la Cina per il dominio dei mercati e delle materie prime del pianeta sta mettendo a nudo una realtà profondamente diversa dalle fantasiose narrazioni dell’unipolarismo statunitense e dei suoi gregari europei, mentre si rafforza una tendenza al multipolarismo orientata dal cartello dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) a cui si sono aggregati nell’ultimo anno sempre più numerosi Stati del pianeta, e le adesioni si vanno moltiplicando. La crisi è occidentale, e il cuore della crisi è costituito dalla situazione interna agli Stati Uniti, alla vigilia di una drammatica guerra civile e interetnica che già sta determinando conseguenze prevedibili nell’intera area di influenza atlantica.
La guerra statunitense ed europea in Ucraina, per spezzare le reni alla Russia, è perduta; il taglio dei finanziamenti statunitensi al governo vassallo di Kiev e la conseguente riduzione degli aiuti militari europei costringeranno a una soluzione negoziale sulla base degli accordi di Minsk del 2015, in un paese desertificato da nove anni di guerra del tutto inutili nel cuore dell’Europa; l’unico risultato strategico del massacro resterà un precario dominio statunitense sull’Unione Europea, e qualche profitto momentaneo nel commercio delle armi e del gas liquefatto. La strategia dell’ampliamento della Nato a est, in funzione antirussa, è compromessa.
Con i risultati delle recenti elezioni politiche a Taiwan, che determinano una situazione di necessaria coesistenza pacifica tra il governo dell’isola e la Repubblica popolare cinese, è compromesso il ruolo di Taiwan come testa di ponte militare in funzione anticinese. La visione strategica lungimirante del Partito comunista cinese, qui come altrove, governerà la situazione.
Ma il dato nuovo, del tutto imprevisto nello scenario internazionale della crisi occidentale, viene dal Medio Oriente. L’azione militare della resistenza palestinese, il 7 ottobre, per rompere l’assedio israeliano di Gaza e riaprire clamorosamente una questione palestinese data per sepolta dall’occupazione israeliana, ha messo a nudo la strategia sionista del “colonialismo di insediamento” (l’eliminazione della presenza palestinese da Gaza e dalla Cisgiordania, iniziata con la Naqba del 1948 e perseguita sistematicamente da allora a oggi, di guerra in guerra, moltiplicando gli insediamenti coloniali, rendendo impraticabile uno Stato palestinese), provocando reazioni nell’intero mondo arabo e islamico che hanno fatto fallire il disegno di normalizzazione delle relazioni tra lo Stato ebraico e gli Stati arabi. A quale prezzo? L’azione militare del 7 ottobre che è stata considerata da Israele “il nostro 11 settembre”; è molto di più. L’attentato alle Torri gemelle, sulla cui natura ci si sta ancora interrogando, fu un’azione priva di visioni strategiche in chi la realizzò, e soprattutto alimentò le politiche di guerra dell’impero statunitense (in Afghanistan e altrove). L’azione del 7 ottobre rientra invece in una precisa strategia della resistenza palestinese che, sviluppando processi unitari tra le diverse organizzazioni, da Hamas al Jihad islamico, a Fatah, alla sinistra del movimento di resistenza (Fronte popolare, Fronte popolare democratico, comitati popolari in Cisgiordania, ecc.), ha avuto l’obiettivo di riaffermare la centralità della lotta di liberazione palestinese. Sulla dinamica dell’azione del 7 ottobre non sappiamo se il governo israeliano sia stato preventivamente informato dai suoi servizi su quanto stava per accadere, e lo abbia lasciato accadere per rispondere con una dura rappresaglia nell’interesse personale di Netanyahu e delle strategie dei partiti più oltranzisti del suo governo (espulsione dei palestinesi, ricolonizzazione di Gaza, pulizia etnica in Cisgiordania), ma è certo che l’eliminazione di numerose basi e postazioni militari israeliane e la cattura di centinaia di ostaggi da scambiare con le migliaia di prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane, hanno rappresentato per Israele una dura sconfitta tattica, e per la resistenza palestinese la riapertura di un processo di liberazione. Non all’attentato dell’11 settembre è paragonabile l’azione del 7 ottobre, quanto piuttosto all’offensiva del Têt con cui, nel gennaio 1968, nel Vietnam del sud, i vietcong, sbucando del tutto imprevisti dalle loro reti sotterranee di rifugi e tunnel, invertirono le sorti della guerra statunitense, a prezzo di sanguinose rappresaglie contro i civili ma infliggendo agli occupanti una dura sconfitta strategica, all’origine dello stesso movimento contro la guerra americana in tutto il mondo.
Le conseguenze del 7 ottobre sono sotto gli occhi di tutti: una feroce rappresaglia contro i civili palestinesi di Gaza (25.000 morti, di cui 16.000 donne e bambini – un vero investimento produttivo, demografico –, decine di migliaia di feriti e dispersi, un centinaio di giornalisti assassinati), la deportazione a colpi di bombardamenti dell’intera popolazione di Gaza per spingerla verso il deserto del Sinai, lo stillicidio di attacchi militari dei coloni israeliani in Cisgiordania, armati e protetti dall’esercito. Una nuova Naqba, una “soluzione finale” nelle intenzioni dello Stato ebraico. Per le popolazioni del mondo arabo e islamico, per i movimenti di solidarietà con la resistenza palestinese anche in Occidente, un genocidio nella peggiore tradizione del “colonialismo di insediamento” sionista. Gli “accordi di Abramo” (escludendo i palestinesi) di normalizzazione delle relazioni con l’Arabia saudita e gli altri Stati arabi sono saltati; gli Stati Uniti, il grande protettore e complice di Israele in funzione anti-iraniana, costretti a inventarsi un ruolo improbabile di “mediatori di pace”. Israele ha ridotto Gaza in macerie (e a Tel Aviv le agenzie immobiliari raccolgono prenotazioni per alberghi e stazioni balneari nella striscia), ma ha diminuito solo parzialmente la forza militare di Hamas e delle altre formazioni palestinesi, e l’esercito rischia di dover affrontare una guerriglia di lunga durata a Gaza e in Cisgiordania, mentre a fianco dei combattenti palestinesi si sono schierati gli Hezbollah in Libano, gli Huthi in Yemen, e cominciano a formarsi in tutto il mondo arabo gruppi di sostegno attivo, anche militare, alla resistenza palestinese. Il canale di Suez è di nuovo uno scenario di guerra.
Lo Stato ebraico è isolato. Ed è stato un paese dei Brics, il Sudafrica, a trascinarlo l’11 gennaio davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, tribunale dell’Onu, con l’accusa di genocidio. La patetica autodifesa di Israele (il genocidio è quello del 7 ottobre nei nostri confronti; e poi non siamo processabili avendo subito il genocidio nazista) non ha scalfito l’accusa di perseguire dal 1948 politiche di espulsione e apartheid della popolazione palestinese nei territori occupati della Cisgiordania, e di sterminio oggi a Gaza; il 20 gennaio, in Uganda, il “Movimento dei paesi non allineati”, riunito nel suo 19° summit, si è concluso con una Dichiarazione di Kampala nella quale 120 paesi che rappresentano il 55% della popolazione mondiale hanno condannato il genocidio del popolo palestinese, rilanciando l’iniziativa del Sudafrica presso la Corte di giustizia dell’Aja; nella stessa occasione il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ricordando i 152 impiegati dell’Onu morti sotto le bombe a Gaza, ha intimato ancora una volta a Israele di interrompere il massacro.
Intanto cominciano a farsi sentire in Israele le conseguenze della guerra: troppi i riservisti impegnati sui diversi fronti e sottratti al mercato del lavoro, forte riduzione di lavoratori palestinesi, pesante contrazione di commesse industriali e commerciali dall’estero. Ed è auspicabile che nei prossimi mesi le proteste della maggioranza della popolazione ebraica contro il corrotto Netanyau che usa la guerra per difendersi dai suoi processi, lasciando al loro destino gli ostaggi del 7 ottobre, escano dal recinto militarizzato di cui sono prigionieri, più o meno volontari.
E l’Europa? I costi della fallimentare guerra ucraina, scaricati dagli Stati Uniti sull’Unione Europea, stanno danneggiando l’economia europea. Privati del gas russo, sostituito dal gas statunitense molto più caro, gli Stati nazionali sono alla ricerca di fonti (fossili) in Africa e in alcuni paesi dell’est europeo, mentre la transizione ecologica dal fossile alle fonti rinnovabili non è perseguita con la necessaria determinazione nonostante la propaganda green, e il nucleare, a parte le centrali esistenti, generalmente obsolete, richiede tempi lunghi di realizzazione. Svuotati gli arsenali militari per rifornire l’avamposto ucraino, in tutti i paesi aumentano le spese militari, in una situazione economica di decrescita infelice. La Germania socialdemocratica si riarma, ed è in recessione. L’altro paese guida dell’Unione Europea, la Francia, espulsa dall’Africa in ragione del suo inveterato colonialismo, è costretta ad appellarsi alle vetuste glorie di una grandeur d’antan, in nome di un pragmatico «bon sens» (Macron, 17 gennaio) in un paese percorso da conflitti sociali endemici e irrisolti. Nell’Unione Europea si vanno accentuando le differenze tra gli interessi nazionali, tra nord e sud, e il fragile collante dell’unione economica si va sgretolando, alla vigilia di elezioni che non parleranno di politiche europee e non usciranno dalle dimensioni nazionali degli Stati; una parvenza di unione politica, mai perseguita se non attraverso la propaganda dei media, si è dissolta con la sconfitta della guerra in Ucraina. Quale ruolo per l’Europa in un mondo multipolare? Quale ruolo nella crisi del capitalismo finanziario? Nella crisi climatica? Molte le domande, confusi balbettii le risposte.
E in Italia? L’attuale governo di destra, espressione minoritaria della crisi del sistema politico italiano e della tradizione fascista e neofascista, nel contesto della crisi profonda di una sinistra perduta, è un governo da tempo di guerra. Atlantista e bellicista, gregario della geopolitica statunitense e della Nato, in prima linea nel sostegno politico-militare all’Ucraina e a Israele, ha il compito di fare il lavoro sporco che il governo “progressista” di Draghi, espressione del neoliberismo della finanza internazionale, non era opportuno che svolgesse. È impiegato come carta di riserva provvisoria per lavorare “ai fianchi” lo Stato di diritto costituzionale: l’Italia non ripudia la guerra anzi la promuove, il mercato delle armi è un ottimo investimento produttivo, la militarizzazione del controllo sociale, l’occupazione autoritaria delle catene di comando, l’incremento del precariato giovanile contrabbandato come nuova occupazione, la svendita di asset strategici a fondi finanziari dell’area atlantica, la liberalizzazione dell’evasione fiscale e delle rendite, l’attacco al controllo della magistratura, alla sanità e alla scuola pubblica, la guerra ai poveri e agli immigrati, la divisione del paese attraverso progetti di autonomia differenziata, l’assenza di politiche industriali e di contrasto ai cambiamenti climatici, il campo libero ai traffici dei lobbisti in ogni settore. La sintesi della torta è la concentrazione dei poteri nel capo del governo. Insomma, sfiancare l’assetto costituzionale del paese, deformando la stessa Costituzione del 1948 per contrapporle una pretesa costituzione materiale di tradizione autoritaria e fascista. Il controllo dei media permette di spacciare uno stillicidio di decreti legislativi settoriali come “riforme” innovative, e la sottocultura di destra come nuova egemonia. L’opposizione parlamentare? È il governo a dettare l’agenda. Mentre nell’area di governo, in una situazione di premierato di fatto, si moltiplicano gli episodi e le tensioni di una guerra per bande.
Per i meccanismi di uno sciagurato sistema elettorale, questo governo “di guerra” è maggioritario nel Parlamento e minoritario nel paese, in un paese in cui la crisi della politica (parafrasando Tacito sulla pace e la guerra, hanno fatto un deserto e l’hanno chiamato politica) ha prodotto un astensionismo crescente: metà del paese non vota, e in gran parte si tratta di astensionismo attivo, di non collaborazione con un sistema di profittatori (la politica come questione privata, occupazione personale di ruoli nel sistema) e ladri di futuro. Quanto potrà andare avanti questa farsa di fascisti sedicenti democratici, pessimi gestori dell’economia e dello Stato, alla vigilia di prevedibili disastri politici ed economici nella gestione delle immense risorse del Pnrr e della vita quotidiana della popolazione (lavoro, occupazione, fiscalità, servizi pubblici)? I vincoli di un commissariamento “alla greca” (patto di stabilità) e i sovradeterminati poteri della finanza internazionale renderanno vane le fantasie retoriche sull’esercizio emergenziale del comando. I disastri delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente accelereranno processi implosivi e reazioni sociali.
L’unica alternativa è il socialismo. La pace non è soltanto l’assenza di guerra, è giustizia sociale, egualitarismo, liberazione dalla preistoria del capitalismo, liberazione delle potenzialità umane in una società di tutti in cui il potere sia di tutti e la “democrazia” sia reale. La democrazia come “potere di tutti” è un processo rivoluzionario di esperienze e situazioni di contropotere, dal basso, preparando le soggettività del cambiamento all’esercizio di un nuovo potere fondato sulla democrazia diretta e delegata con controlli dal basso. Non si tratta di sostituire una classe dirigente “democratica” a una classe dirigente oligarchica lasciando intatta l’organizzazione della società, i suoi attuali rapporti di produzione e di proprietà. Si tratta di rovesciare dal basso la piramide sociale, forti delle esperienze storiche dell’anarchismo, del socialismo e del comunismo critico, costruendo reti sociali di progettazione e di azione politica in una prospettiva di massimo socialismo e massima libertà, costruendo potere di resistenza e opposizione per poi esercitare la liberazione del “potere di tutti”. In molti casi si tratta di riprendere cammini interrotti e rimossi dalla sinistra di sistema, quella “sinistra” di cui Luigi Pintor aveva decretato la morte già negli anni novanta e che si è fatta destra, ruota di scorta di un sistema politico ed economico irriformabile. È questo il terreno fecondo di tante esperienze in corso: dalle reti sociali sulle tematiche dei “beni comuni”, ai comitati di cittadinanza attiva sulle tematiche ambientali, alle esperienze di cooperazione tra associazionismo ed enti locali, alle reti di insegnanti e studenti impegnati nella difesa della scuola pubblica, al sindacalismo attivo nei luoghi di lavoro, alle pratiche interculturali e di accoglienza degli immigrati, e il quadro, nelle sue positive diversità, è aperto e in divenire. La creazione di relazioni sociali di tipo nuovo, orizzontali e partendo dal basso, dalle periferie, fondate sulle persone attive come “centri” di un potere di tutti costruito nelle situazioni concrete, sulla conoscenza, la critica e l’informazione, sul controllo e la disarticolazione delle catene di comando oligarchiche, libera straordinarie potenzialità di uomini e di donne e prepara la libera autonomia di tutti, per una realtà che è comunque e sempre di tutti.
Questa la risposta alle guerre delle oligarchie: creare, organizzare società di persone consapevoli e attive, moltiplicando esperienze e situazioni di autonomia e di potere dal basso. In questo momento, in Italia, si vanno costruendo esperienze di radicale estraneità ai riti di un sistema politico sempre più concentrato, isolato e screditato; il fallimento del neoliberismo di una sinistra perduta, alla vigilia di bombardamenti economici senza precedenti, ha prodotto guasti profondi, politici e culturali, in un’opinione pubblica sempre più disorientata e disinformata dai media, e il governo di destra commissariato da un’Unione Europea (che non è l’Europa, di cui fa storicamente parte anche la Russia) al servizio delle strategie di guerra economica e militare degli Stati Uniti e di una Nato che non dovrebbe neppure esistere dopo l’implosione dell’Unione Sovietica, tenterà invano di “governare” processi ingovernabili se non con i soliti mezzi di distrazione di massa affidati a una politica tutta televisiva. La nuova composizione di classe di una società sempre più impoverita e in declino demografico, il nuovo proletariato precarizzato e implementato da settori estesi di ceto medio, favoriscono la ripresa di lotte sociali radicali e una necessaria ricerca di nuove soluzioni progettuali e di visione. L’esperienza della lotta in corso del collettivo della ex Gkn di Campi Bisenzio, dalla fabbrica al territorio, alla costruzione di una rete nazionale di esperienze di autorecupero di fabbriche in crisi, alla cooperazione con i giovanissimi di Fridays for Future e ai movimenti contro la guerra, è un esempio significativo di questa fase della lotta di classe in Italia.
Si stanno moltiplicando le occasioni di confronto politico e culturale sulle questioni fondamentali: quale società, quale pace, quale socialismo. È il momento di attivare collegamenti, confronti, progettazioni e iniziative. La questione fondamentale è un socialismo senza aggettivi, in tempi di guerra e di catastrofe climatica a minaccia di estinzione della specie umana.
Il nostro programma 2024, per un programma collettivo socialista. «Il Ponte», dal 1945 cantiere di elaborazione teorica sulla linea dell’antifascismo liberalsocialista degli anni trenta-quaranta, delle esperienze di democrazia diretta “omnicratica” e socialista libertaria sperimentate da Capitini nell’immediato dopoguerra, e negli anni sessanta sui temi della pace e della guerra, è oggi più che mai un cantiere aperto, e uno strumento di collegamenti e iniziative condivise. Nel 2024 «Il Ponte» compie 80 anni. Un lungo viaggio iniziato nel 1945 da Piero Calamandrei e dai liberalsocialisti toscani (Tristano Codignola, Enzo Enriques Agnoletti) in stretto rapporto dalla metà degli anni trenta con i liberalsocialisti umbri (Aldo Capitini, Walter Binni), proseguito dal 1956, alla morte di Calamandrei, con la direzione di Enriques Agnoletti, e dal 1986, alla morte di Enriques Agnoletti, con la direzione di Marcello Rossi. In tutti questi anni, «Il Ponte» ha svolto e continua a svolgere una funzione di cantiere di confronto ed elaborazione progettuale di un nuovo socialismo libertario, con uno sguardo sempre attento alle esperienze storiche dei socialismi nell’Ottocento e nel Novecento, in tutte le loro declinazioni, e ai processi in corso nella contemporaneità.
Siamo una rivista e una casa editrice, consapevoli dei nostri limiti di azione politica e culturale, ma decisi a promuovere le funzioni di quei Centri di orientamento sociale (Cos) sperimentati da Capitini nel 1944-48, per contribuire – in relazioni di rete – alla definizione di un programma di nuovo socialismo. La situazione italiana attuale ci impone di rafforzare la nostra rete di collaboratori per un’attività di progettazione collettiva su alcuni temi necessari e urgenti. In primo luogo le questioni del lavoro; la rivista le affronterà in una nuova rubrica gestita dalla Cgil toscana e dall’Istituto di ricerche economiche e sociali. Un’altra nuova rubrica, dedicata ai problemi della cooperazione, sarà gestita dalla Lega toscana delle Cooperative; dal 2000 «Il Ponte» è una cooperativa aderente alla Lega. Il rapporto di collaborazione con la Cgil e con la Lega permetterà di organizzare incontri e iniziative in varie situazioni territoriali, per «ascoltare e parlare» secondo il metodo capitiniano dei Cos. Due numeri speciali della rivista saranno dedicati a questi problemi. Un terzo numero speciale sarà dedicato alla questione centrale dei cambiamenti climatici, da affrontare scientificamente e politicamente; il numero sarà curato da Giuliano Pelfer. Nei tre numeri ordinari della rivista proseguiremo le nostre analisi politiche e culturali in un anno che sarà decisivo per l’assetto geopolitico del mondo, per orientarci e orientare sui processi in corso, per definire i temi essenziali di un programma socialista da costruire dal basso. In stretto rapporto con la rivista, proseguirà l’attività della casa editrice.