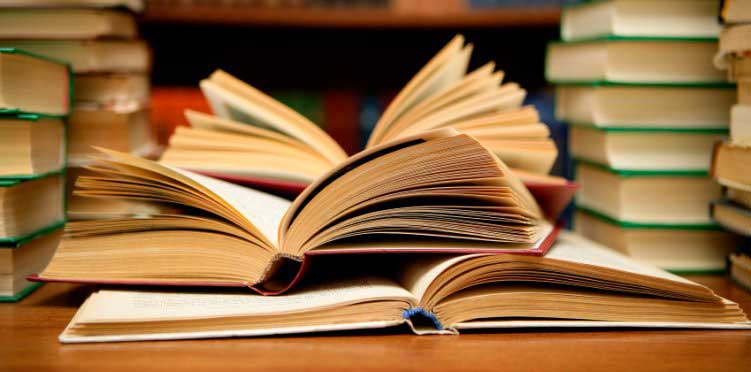1. A cosa serve la teoria della letteratura? In un mondo di teorici e di “discorsi teoretici” (secondo la formula di Fredric Jameson), a poco o a nulla: la famosa legge della saturazione regna sovrana anche nel campo, per costituzione ibrido e dinamico, della teoria letteraria. Ma la superfetazione di metodi, prima, e teorie, poi – gli uni, figli minori della sbornia strutturalista degli anni sessanta e settanta; gli altri, nipoti sparsi della decostruzione americana e di un marxismo spoglio di pretese totalizzanti –, se segnala un’esigenza, dimostra altresì di riflettere un disorientamento collettivo, un’errabonda incapacità di darsi punti fermi e di calibrare in modo non troppo superficiale il lavoro teorico. Che, d’altro canto, non è un lavoro da specialisti – e in ciò si potrebbe rintracciare la sua natura oppositiva e non-conciliativa, la sua distanza dall’accademismo –, ma un lavoro che pur necessita della padronanza – Edward W. Said direbbe “dilettantesca”, ossia non ideologicamente professionistica – di ampi spazi di sapere. E, allora, la proliferazione di teorie non può spiegarsi semplicemente con il motivo ricorrente della scomparsa dell’umanesimo o delle lyotardiane grandi narrazioni: piuttosto, essa oggi è l’esito, spesso inconsapevole, di un qualche frattura più profonda, le cui ragioni storiche non possono essere negate o sorvolate con superficialità. L’esplosione frammentaria di correnti teorico-politiche, di metodologie di lettura le più disparate, di un marxismo che rincorre il suo stesso fantasma, di aree di approfondimento culturale contrassegnate dalle mode della differenza e dell’autonomia, riconsegna l’immagine di una teoria che, snaturandosi, è diventata essa stessa un genere, un comparto specialistico del sapere, una formula di comodo, o forse, semplicemente, una disciplina sottomessa al diktat della specializzazione. E ciò è avvenuto perché la teoria, reificandosi nella costruzione di un armamentario concettuale astruso e autoreferenziale, ha perso il ben noto contatto con la realtà, con lo spazio della politica: ha perso, per dirla in breve, quella capacità di immaginazione sociologica che non solo le dava una dignità culturale, ma la candidava a essere la protagonista di un lavoro culturale che potesse dirsi militante e costruttivo.
In tal senso, la “teoria” è ben presto divenuta un’etichetta di consumo, al di là delle sue caratterizzazioni settoriali. Si pensi al recente fenomeno dell’Italian Theory – una sorta di cartello commerciale (un brand, dicono gli amici del capitale) nato per diffondere un supposto genio italico e fondato su un essenzialismo manieristico, una sorta di culto del “particulare”, tanto goffo quanto inconsistente. O si pensi, ancora, all’appeal che certi teorici-sciamani – quasi sempre cripto-cattolici insofferenti alla dottrina, eppure ligi al dovere ultimo di credere in un metafisico e irraggiungibile Grande-Altro – emanano discettando su qualunque inezia, mescolando ectoplasmi pseudo-marxisti alle apparizioni più varie del postmodern way of thought: Slavoj Zizek ne è un esempio pressoché paradigmatico. Sicché, per farla breve, da possibilità argomentativa capace di mettere assieme la particolarità del sapere con l’universalità della militanza, la teoria si è mutata in un discorso generalista sull’esistente – in Italia, quasi sempre moderato – e in un’indisciplinata confluenza di micro-conoscenze, dietro cui non si cela certo un quadro di riferimento o una presa di posizione, ma una quietistica e pacifica anarchia. Il discorso teorico ne risulta annacquato, sterile, passivo. Anzi, si potrebbe persino dire che quell’immaginazione sociologica cui accennavamo non si presenta più quale presupposto dell’agire politico, ma come qualcosa di posto, di conseguente, di successivo, e dunque di aderente allo spirito dei tempi.
Del resto, l’adesione conciliativa della teoria ha come suo rispecchiamento la forma estetizzata che essa ha assunto. I teorici contemporanei mirano alla scrittura, desiderano lo stile. Nulla di male, per carità: se non fosse che la capacità espressiva della teoria non dovrebbe essere l’unico e solo risultato da raggiungere, non dovrebbe porsi come l’obiettivo narcisistico ed espositivo dell’argomentazione. Lo stile concettuale dei grandi pensatori è inscindibile dal loro sforzo argomentativo. Lo stile di Hegel o di Kierkegaard è tutt’uno con l’inesorabilità del ragionamento – e non c’è nulla di male (anzi!) nel constatare che una supposta trascuratezza stilistica sia vittima della chiarezza espositiva. Quel che si nota oggi nella teoria contemporanea, o nel saggismo culturale tout court, è l’egemonizzarsi di una prosa concettuale nebulosa, che, al netto delle sue mirabolanti citazioni colte e raffinate, nasconde un vuoto di chiarezza, un’inadeguatezza a esprimere in modo netto il pensiero. Essa mira all’emozione, o all’esposizione di un simulacro scrittorio di valenza estetica. I libri di Terry Eagleton, per fare un esempio, mostrano perfettamente la tendenza all’espressività ironica, talvolta davvero sagace e interessante, ma fissano l’attenzione del lettore non sul supposto impegno politico che l’autore vorrebbe palesare, quanto sulle mirabolanti angolature della prosa, sul suo capriccioso e umorale andirivieni. I saggi di Gayatri C. Spivak rappresentano, di questi limiti, il riflesso, per così dire, rovesciato: è l’inesplicabilità del suo concettoso argomentare – spigoloso, disorientante, incomprensibile – a essere esibita, in un modo che forse potremmo persino chiamare elitaristico o snobistico. E via dicendo.
È sufficiente un occhio meno intellettualistico sull’oggi per comprendere che la teoria è diventata un’articolazione della cosiddetta “Cultura”: un fenomeno che negli anni ottanta veniva salutato, anche in Italia, come liberatorio, ma che ben presto si è rivelato, nell’intimo, aderente al capitalismo contemporaneo. L’egemonia della Cultura – un tempo, solo e soltanto “cultura di massa”; oggi, qualcosa di più onnicomprensivo, che ingloba il cosiddetto discorso culturale “alto” – ha prodotto una vera e propria rivoluzione antidialettica: ha decostruito nel profondo le ragioni di una conoscenza critica e politica dell’esistente, ha destituito il lavoro culturale, spogliandolo della sue determinazioni concrete, ha annebbiato la vista degli intellettuali, costringendoli al ruolo di servi passivi o di sudditi de-responsabilizzati, e seducendoli con la promessa del successo. A queste spinte alienanti di frammentazione e distruzione del sapere – cui corrispondono, soprattutto per quelli che oggi chiamiamo “operatori della conoscenza”, strategie compensative di estetizzazione della vita quotidiana – si può reagire, per chi scrive, solo con la consapevolezza di trovarsi all’interno di una totalità amministrata in cui la possibilità del contrasto è subito rigettata nella mischia dell’adesione e del consenso pacificato. Il dissenso, per dirla con una formula paradossale, fa bene al capitale. Fa bene al capitale leggere Impero o discutere di Pasolini; fa bene al capitale leggere questo intervento. Perché titoli, nomi o appunti, questi ultimi, non più sentiti come un pungolo dialettico o come una possibilità di reale interrogazione, ma ridotti a necessarie e illusorie etichette di garanzia per la “libertà d’espressione” o per la presenza salvifica della Cultura che il nichilismo contemporaneo ci impone, anche quando ne siamo, parzialmente o totalmente, consapevoli.
2. E, allora, si dirà, con vecchio motto leniniano: che fare? Che destino ha il discorso teorico – dietro il quale, si badi, vorremmo riconoscere il discorso culturale tout court, ossia un sapere non disciplinare mai scisso dalla comprensione critica di ciò che ci circonda? Nei Quaderni del carcere, Gramsci scrive: «Se il problema di identificare teoria e pratica si pone, si pone in questo senso: di costruire, su una determinata pratica, una teoria che coincidendo e identificandosi con gli elementi decisivi della pratica stessa, acceleri il processo storico in atto, rendendo la pratica più omogenea, coerente, efficiente in tutti i suoi elementi, cioè potenziandola al massimo; oppure, data una certa posizione teorica, di organizzare l’elemento pratico indispensabile per la sua messa in opera. L’identificazione di teoria e pratica è un atto critico, per cui la pratica viene dimostrata razionale e necessaria o la teoria realistica e razionale»[1]uaQ. La dialettica descritta da Gramsci è andata persa, o si è trasformata in altro: un’universalità diversa chiude in sé, in modo strangolatorio, l’elaborazione teorica e la prassi politica quotidiana, ne detta i legami, ne stravolge le rispettive capacità. E allora, alla consapevolezza dell’inestricabile nesso che l’azione culturale oggi rischia di avere con le ragioni del capitalismo (volendo chiamare così un nemico dalle mille facce) va aggiunta l’intelligenza della necessità, ossia la riabilitazione di una tensione conoscitiva totalizzante, che miri a non porsi quale particolarità settoriale, ma punti, infrangendo i codici disciplinari, a rispecchiare il movimento, sempre dinamico, sempre costante, del tutto, e a ritrovare in esso le ragioni del contrasto e dell’opposizione – ragioni che non possono appagarsi d’essere interne alla dialettica tra sapere e potere imposta dal capitale, ma che devono ambire a costituirsi come totalità alternativa, nelle forme di un lavoro culturale che va, senza dubbio, rielaborato in funzione anti-intellettualistica. Per dirla con un motto, una teoria davvero all’altezza dei tempi ha l’obiettivo, solo apparentemente apocalittico, di smarcarsi dalle forme che la teoria ha assunto nell’ultimo quarantennio. E, di conseguenza, il suo prodotto sarà un’idea di cultura del tutto antitetica al mantra culturale contemporaneo.
La teoria della cultura, in questa prospettiva, assume un’insperata attualità. Se il suo oggetto è l’emersione dei fatti culturali e la riconduzione di questi ultimi a ragioni altre, è presto detta anche la sua finalità politica: che a me pare la comunicazione a tutti di un modello alternativo di totalità o la messa in evidenza di quella totalità che gli oggetti culturali prefigurano e, in alcuni casi, contestano. E, ancora, appare essenziale il recupero dell’ottica gramsciana: se il lavoro culturale si rivolge a possibilità collettive che devono essere rielaborate, l’oggetto del suo riflettere dovrà essere il più largo possibile, non potrà limitarsi ai prodotti della cultura alta o di un umanesimo tradizionale vagheggiato e reso come nostalgico termine di paragone. È forse il solo modo, questo, di ristabilire le tanto agognate gerarchie offerta dal giudizio di valore: purché i parametri di tale giudizio cambino, assieme all’obiettivo reale della conoscenza critica.
A dispetto dell’incremento di una certa saggistica intellettualistica e radical – che riesce a tenere assieme Marx e la battaglia contro l’euro, Lacan e i cattolici, Toni Negri e i revival sessantotteschi, nelle forme euforiche della pop-filosofia (dice qualcuno): esiti, questi, di una borghesia di sinistra scoppiata e infestata da rigurgiti destrorsi, comunque manifestazione diretta di una vocazione maggioritaria al moderatismo e al qualunquismo –, raramente si scrive vera teoria in Italia, e raramente si coglie, tra i libri dell’accademia, un discorso teorico, magari anche autoreferenzialmente chiuso nel suo oggetto, capace tuttavia di ridare linfa a uno sforzo rielaborativo sull’esistente. Perché – è bene dirlo – non ci si aspetta qui di leggere teoria impegnata, quanto di ricevere sollecitazioni per un orientamento concettuale che sia utile a comprendere e a scompaginare la nostra posizione sulla scacchiera della realtà. Pochi sono i casi in cui, almeno per chi scrive, questa tensione – lo ripetiamo: anche criptica o celata – viene comunicata dall’intelligenza del ragionamento.
Tuttavia, senza cedere alla nostalgia delle pagine di Francesco Orlando o di certe intuizioni filosofiche di Giacomo Debenedetti, più interessante è chiedersi se vi sia nelle giovani generazioni un ritorno alla teoria. Chi si è formato, come lo scrivente, a cavallo tra gli anni novanta e duemila, ha vissuto il tracollo definitivo degli statuti teorici e le conseguenze nefaste delle mutazioni interne al quadro disciplinare della teoria letteraria. Al lavoro del teorico non si è sostituito, come qualcuno pensa, quello del critico quotidiano consapevolmente residuale, ossia senza velleità di universalizzazione teorica: non si è semplicemente passati dalla pienezza dell’umanista al relativismo del lavoratore della conoscenza. Piuttosto, nei trentenni d’oggi, si vede sorgere la figura fintamente libertaria del critico freelance, che danza con passo felpato tra blog e festival della letteratura, che sì scrive sui supplementi culturali delle testate giornalistiche (sia di sinistra che di destra, a dire il vero) come i suoi “padri”, ma che, a differenza di costoro – comunque attivi in una società in cui il Noi aveva senso –, sembra tutto teso a celebrare il grande Io del critico censore, un po’ goffamente, un po’ stupidamente, cercando quasi sempre la polemica, il battibecco, la chiacchiera salottiera (quando non viene tentato dalla letteratura stessa). Si dirà: anche i critici novecenteschi – Fortini, Asor Rosa, Cases, i più giovani Luperini, Berardinelli, Bellocchio – in fondo miravano al dissenso e alla discussione, spesso esibendo con magniloquenza la propria identità irrinunciabile di intellettuali o di scrittori. È vero. E tuttavia, non si può non riconoscere nelle loro pagine un legame sempre vivo tra la loro parzialità di lettori e la verifica sociale di un qualche destinatario. Motivo per cui, anche quando condotti con intelligenza e sagacia, i ragionamenti dei critici trentenni d’oggi accettano implicitamente di inscenarsi nel finto teatrino della società letteraria, e ne risultano irrimediabilmente corrosi, infiacchiti, intossicati. Proprio perché rinunciatari rispetto all’interrogazione teorica del proprio statuto e del sapere che frequentano. Sarebbe arduo sostenere la tesi, sempre paternalistica, che in queste figure – amate da una sinistra che ha sempre preferito i grandi Narcisi ribelli – sia da riconoscersi un possibile soggetto rivoluzionario.
3. Qualche eccezione, nelle giovani generazioni, è lecito però ritrovare in coloro i quali tentano di riabilitare le ragioni della teoria letteraria con il beneficio della riflessione pacata e dell’attenzione sempre presente alla storicità dell’esperienza umana, distinguendosi dall’usuale discorso impressionistico sulla letteratura che spadroneggia nelle tribune culturali del nostro paese. È a questi costruttori silenziosi di ragionamento che, forse, occorre guardare, in modo tale che l’energia della riflessione venga poi convogliata nella sperata ricostruzione di un modello differente di impegno culturale.
Fra questi, v’è sicuramente il trentenne Stefano Ercolino, che con Il romanzo massimalista, di recente traduzione italiana[2], ha consegnato al lettore un tentativo teorico coraggioso e sicuramente inusuale per il lettore italiano. L’oggetto di studio è rappresentato da ciò che l’autore definisce come un «nuovo territorio concettuale»[3] in grado di ridefinire i contorni della postmodernità letteraria, alla quale, negli ultimi decenni, ci siamo forse accostati con definizioni di comodo o incauti adattamenti. Ercolino prende in esame una serie di romanzi usciti tra il 1973 e il 2005 – per la precisione: L’arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, Infinite Jest di David Foster Wallace, Underworld di Don DeLillo, Denti bianchi di Zadie Smith, Le correzioni di Jonathan Franzen, 2666 di Roberto Bolaño e 2005 dopo Cristo di Babette Factory – per studiarne l’identità strutturale e formale, e verificarne l’appartenenza a una certa totalità storico-espressiva, che rimanderebbe all’emersione di alcuni elementi o connotati dell’attuale epoca postmoderna. È chiaro che la posta in gioco rifletta di per sé la mappa filosofica entro cui l’autore si muove: Ercolino ragiona in termini di dinamismo, di emersione, di totalità, non si appaga di una concezione statica e regressiva del testo letterario e rifugge da qualsiasi tentazione essenzialistica e disciplinare: sceglie, insomma, la strada della dialettica e della verifica, e concepisce la teoria, o, potremmo dire, la volontà sistematica, come costante terreno di validazione e di apertura alla contraddizione. Si riconosce, inoltre, in questo libro – come, del resto, nell’altro importante contributo di Ercolino, The Novel-Essay[4] – una costante capacità di svolgere il discorso teorico mantenendo in contatto l’ordine dei problemi letterari (ossia, la dimensione giocoforza specialistica del sapere entro cui il teorico si muove) con l’ordine politico dell’esistente (cosicché il ragionamento sulla storicità delle forme è sempre e comunque un ragionamento sulla postmodernità come categoria storica e sul presente come problema politico).
Mi pare di riconoscere un primo merito del libro nelle scelta di ordire un discorso teorico consapevolmente rispettoso della transitorietà storica del suo oggetto di studio. L’ottica dialettica attraverso cui Ercolino guarda ai romanzi massimalisti – definizione che sceglie in ragione di alcune costanti formali e contenutistiche – permette di esibire la processualità che caratterizza l’emersione dei testi e i tentativi teorici di diagnosticarne la natura. Ed è un’ottica dialettica figlia di Hegel e Lukács): non è difficile scorgere in controluce la lezione di Teoria del romanzo, specie quando Ercolino – appoggiandosi anche e soprattutto agli studi di Franco Moretti e della migliore riflessione teorica nord-americana in materia di romanzo – ricongiunge la storicità delle forme letterarie postmoderne agli stadi precedenti dell’epica e della modernità letteraria, al fine di evidenziarne una dimensione storica (potremmo dire persino spirituale) di lunga durata. Dietro la necessità di sistematizzare i caratteri di certa produzione contemporanea massimalista si scorge, pertanto, la pretesa di allegorizzare il cammino storico delle forme, di mostrare il mutamento di certi caratteri, l’egemonizzarsi di altri, il decadere di alcuni. Quando, ad esempio, Ercolino individua nel suo oggetto di studio un forte tasso di “occidentalizzazione” – l’Occidente come ossessione rappresentativa, come unico teatro del rispecchiamento estetico, e di conseguenza il punto di vista occidentale come matrice irriducibile del pensiero sul mondo –, è subito pronto a legare tale caratteristica, diremmo, “strutturale”, a una discontinuità storica, a una variazione delle condizioni storico-materiali, in virtù delle quali la lunghezza del romanzo massimalista, per fare un esempio, «è la condizione necessaria per la radicalizzazione non di un elemento soltanto, ma di una molteplicità di procedimenti»[5].
Agisce, nel ragionamento di Ercolino, una logica dinamica e dialettica che esibisce il carattere costruttivo e storicamente connotato della forma letteraria. Nella sua velleità di contenimento dell’intero mondo, il romanzo massimalista ingloba e manifesta quelle strategie di senso attraverso cui gli individui postmoderni cercano di gestire, amministrare o rappresentare la totalità. E in questa tensione enciclopedica Ercolino non ravvisa un dato di natura. L’autore si sforza, al contrario, di cogliere storicamente le modalità specifiche che una certa epoca – la nostra – elabora per potersi confrontare con il Tutto. Ecco perché risultano di grande fascino, almeno per chi scrive, le pagine in cui Ercolino, attraverso l’analisi puntuale di passi scelti, descrive la particolare dialettica tra frammento e totalità che informa la produzione massimalista, suggerendo al lettore che in questa “amministrazione” (uso il termine non a caso, perché Adorno è senza dubbio uno dei riferimenti costanti dell’autore) della totalità è da vedersi un risvolto materiale, che riguarda da vicino la dimensione alienante del rapporto tra l’individuo postmoderno e la totalità capitalistica. Se «La frammentazione del racconto in unità narrative discrete si fa sistema nel romanzo massimalista», accogliendo elementi che erano già presenti nelle avanguardie di inizio secolo, è allo stesso modo vero che il frammento non denuncia più la sua solitudine, la sua esistenza a-dialettica rispetto al resto, non esalta più il trionfo della sua individualità immanente, ma, piuttosto, «è esso stesso il sistema» – nella fattispecie, «un sistema aperto, frattale, […] espandibile in definitivamente, ma […] regolato da istanze d’ordine perentorie»[6]. Non è forse questa una descrizione mutuabile e riferibile alla condizione che il frammento vive nella totalità destrutturata del postmoderno? Non più la parte è restia a riconoscersi nel tutto, ma pur restando parte è costretta a diventare il Tutto, a divinizzarsi, in una tensione all’infinità che è, in certa misura, amministrata e gestita da una totalità che smonta la qualità stessa delle sue parti, le rende suddite proprio perché le nega come tali, le illude sul piano di una pretenziosa universalizzazione. Figurazione filosofica, quest’ultima, che, intimamente dialettica, apre squarci enormi di riflessione sulle dinamiche della totalità sotto il tardo capitalismo; e che restituisce alla rappresentazione – in un senso che, immagino, Ercolino vorrebbe auerbachiano – un valore appunto figurale e allegorico, qualcosa di più profondo e vero del mero rispecchiamento, e qualcosa di più politico[7].
Del resto, che il romanzo massimalista sia la rappresentazione di un certo tipo di socialità, lo conferma la persistenza di un’ottica polifonica e dei caratteri che essa assume, accanto ad altri, quasi sempre accomunati dall’equilibrio tra la parvenza d’eccesso e di esuberanza e la presenza di una ragione ordinante superiore posta a garanzia di equilibrio. A tal proposito, Ercolino scrive che «nel romanzo massimalista la possibilità di un’azione narrativa unitaria e unificante si perde irrimediabilmente, defluendo in un numero più o meno grande di storie». E tuttavia, non siamo alle prese con un revival modernista, dal momento che la «deflagrazione dell’unitarietà dell’intreccio qui non è dovuta unicamente a uno sperimentalismo formale esasperato, ma al voler includere nella diegesi materiali narrativi sufficienti per almeno tre o quattro romanzi. Non ci troviamo, cioè, di fronte a un difetto di narrazione, ma di fronte a un suo vertiginoso eccesso»: e ciò lascia credere che fra «romanzo massimalista e (un certo tipo di) romanzo modernista» non vi sia alcuna continuità in tema di destabilizzazione dell’intreccio[8]. L’affermazione mi sembra interessante perché proietta sullo sfondo un’ipotesi storica di lunga durata (Ercolino, del resto, insiste spesso su questa necessità storico-filosofica di ampia gettata): il romanzo massimalista lascerebbe emergere la mutazione di caratteri che il modernismo interpretava in modo assai diverso e chiarirebbe così il rapporto che sussiste tra modernismo e postmoderno, e la sostanziale impossibilità di una presenza avanguardistica nella postmodernità, dal momento che il “potere” coercitivo di quest’ultima consiste nella variazione epocale di certe strutture di riferimento, di certi elementi – variazione che chiama il pensiero dialettico a una dinamizzazione di certi facili binarismi concettuali (avanguardia/postmoderno; modernismo/postmodernismo, e via discorrendo).
L’estetica massimalista designa allora uno «spazio narrativo di coralità e digressività» che ha caratteri del tutto nuovi[9]. Anche in tal senso la dicotomia spazio/tempo, per la quale – secondo la tesi di Jameson – la spazialità diverrebbe un elemento predominante dell’immaginario postmoderno (specie nel cinema), a detrimento dell’ottica temporale – sentita come affine alla modernità –, assume nel romanzo massimalista connotati diversi, o sposta il problema verso un’angolatura ulteriore: non più quella antinomica o dicotomica, ma quella dinamico-plurale, in cui le dimensioni spaziali e temporali entrano in conflitto ma non si fissano in una polarità strutturale definita. È, questo, solo un esempio. Ma vale come cartina di tornasole di una più intima necessità che vive al fondo del libro di Ercolino: quella di rivedere certe facili approssimazioni teoriche sul postmoderno, che sembrano, dopo aver percorso il loro lungo tragitto (“viaggiando”, avrebbe detto Edward W. Said), assumere oggi la posa dell’adattamento e dell’universalità.
Del resto, il dibattito sul postmoderno sembra essersi fermato, almeno in Italia, ai lemmi discorsivi degli anni ottanta e dei primi anni novanta: è risultata del tutto assente un’interrogazione militante su temi e motivi che, in ogni caso, la stagione postmoderna aveva esaltato. Il postmodernismo – ossia, la tendenza culturale ed espressiva della postmodernità, per riprendere una distinzione terminologica di successo – è divenuto materia da manuale, un contenitore istituzionalizzato di riferimenti culturali, spesso pensato in una dimensione del tutto statica, in cui la tensione alla parodia vuota, la vocazione al pastiche, la distruzione della temporalità, il dominio dell’orizzontale, finiscono per rappresentare formule fisse e categorie ermeneutiche di comodo. Basterebbe rileggere certe pagine davvero fondamentali di Raymond Williams – anche soltanto quelle basilari di Marxismo e letteratura, per non ricorrere alla fonte marxiana dei Grundrisse e ai passi dedicati alla dialettica tra presupposizioni storiche e loro realizzazione nelle forme pre-capitalistiche – per ribadire che ogni epoca si sostanzia nella perenne transitorietà dei suoi caratteri, e che elementi un tempo “dominanti” possono divenire, in virtù delle continue trasformazioni, “residuali”; altri, un tempo “subordinati”, hanno la possibilità di acquisire valori preponderanti (per riprendere il lessico di Williams)[10]. Se così non fosse, il lavoro culturale sull’egemonia e sulle ideologie non avrebbe senso. E compito della teoria, del resto, dovrebbe essere proprio la negazione di un’ideologia, ad oggi egemone, che promuove l’eternizzazione astorica delle istanze culturali e delle categorie di comprensione. Ercolino cita giustamente, a tal proposito, un libro importante come After the Great Divide di Andreas Huyssen[11], in cui viene restituita un’immagine composita e dinamica della postmodernità: un libro scarsamente noto nel nostro Paese.
Non può essere casuale che Il romanzo massimalista si chiuda con una riflessione sull’impegno e sul realismo. Anche in tal caso, certe ideologizzazioni fin troppo banali hanno contribuito a semplificare una dialettica storica molto più complessa: per molti, il postmoderno segna l’impossibilità del realismo e il trionfo indiscusso del disimpegno. È opportuno pensare, al contrario, in termini dialettici, e riconoscere che la complessità storica vede il relazionarsi di elementi dominanti e di elementi subalterni, di poteri fintamente coercitivi e di resistenze. Il tema dell’impegno ne è un valido esempio: se la distanza del romanzo massimalista dal modernismo si realizza in più frangenti – e anzitutto sul piano di una diversa relazione tra il tutto e le parti –, allo stesso tempo ne scorgiamo un’attenuazione proprio a proposito dell’impegno etico o politico. I romanzi massimalisti condividono con le opere moderniste un’evidente dimensione engagé – Ercolino propone una ricognizione tematica molto precisa e puntuale, in tal senso –, ma declinano l’impegno in forme diverse, meno strutturalmente unidirezionali, nella direzione di un ibridismo etico-politico che difficilmente si comprende adottando gli strumenti categorici della modernità. Ciò per confermare che la dialettica storica delle forme non può leggersi attraverso un facile gioco di negazioni e superamenti. Piuttosto, il momento postmoderno, esaltando la promiscuità, la miscela, la detonazione delle gerarchie, chiama il pensiero a uno sforzo ulteriore, a un’elaborazione concettuale più consapevole della complessità dinamica del divenire. E, in tal senso, il continuo richiamo alla totalità e alle sue strategie di costruzione e interpretazione mi sembra debba leggersi come un invito a non cedere alle lusinghe della semplificazione e alle banalizzazioni della rigidità.
4. Qual è dunque la dimensione politica di uno studio teorico? L’urgenza del qui e ora detterebbe facilmente una risposta, seppure oggi poco frequentata: alla teoria dovremmo chiedere la restituzione di un ordine mentale che combatta – la formula è ancora una volta gramsciana – il caos entro cui sembra muoversi, senza vie di uscita, il nostro tempo. E tale disciplina, che solo per pochi risponde a una necessità, chiama a sé una rielaborazione possibile del rapporto tra la forme artistiche e il contenuto materiale dell’esperienza umana. Ercolino insiste, come abbiamo visto, su un approccio che sia il più possibile scevro da facili opposizioni ideologiche, e che in qualche modo riconquisti un provvisorio momento di identità col suo oggetto storico – la postmodernità come categoria della processualità –, per poi sollevare lo sguardo su un’interezza ulteriore, che è quella, certo più fenomenica, del dinamismo epocale, di una filosofia della storia che ragioni sull’incessante dialettica del cambiamento storico. Mi sembra la strada giusta da percorrere: la riabilitazione di un legame vivo tra la “poetica” delle forme storiche – la loro istanza molteplice di rappresentazione – e le modalità in cui tale poetica esprime un rapporto dell’uomo con la complessità della totalità sociale, si dimostra oggi quanto più necessaria. Pur ammettendo che il nesso tra teoria e prassi non possa rigenerarsi dal nulla, occorre un salto indietro, o forse un balzo benjaminiano – a patto che si indossino i panni del materialista storico –, in virtù del quale ricostruire le istanze della teoria senza dimenticare le urgenze della prassi.
[1] Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, vol. 3, p. 1780.
[2] Stefano Ercolino, Il romanzo massimalista. Da L’arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon a 2666 di Roberto Bolaño, Milano, Bompiani, 2015.
[3] Ivi, p. 9.
[4] Idem, The Novel-Essay, 1884-1947, New York, Palgrave Macmillan, 2014.
[5] Idem, Il romanzo massimalista cit., p. 45.
[6] Ivi, p. 98.
[7] Sulle possibilità dell’interpretazione figurale, rimando a Mario Domenichelli, Lo scriba e l’oblio. Letteratura e storia: teoria e critica delle rappresentazioni nell’epoca borghese, Pisa, Ets, 2011, pp. 215-293.
[8] Stefano Ercolino, Il romanzo massimalista cit., pp. 125-126, 126 e 127.
[9] Ivi, p. 133.
[10] Cfr. Raymond Williams, Marxismo e letteratura [1977], Roma-Bari, Laterza, 1979.
[11] Andreas Huyssen, After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Bloomington, Indiana University Press, 1986.